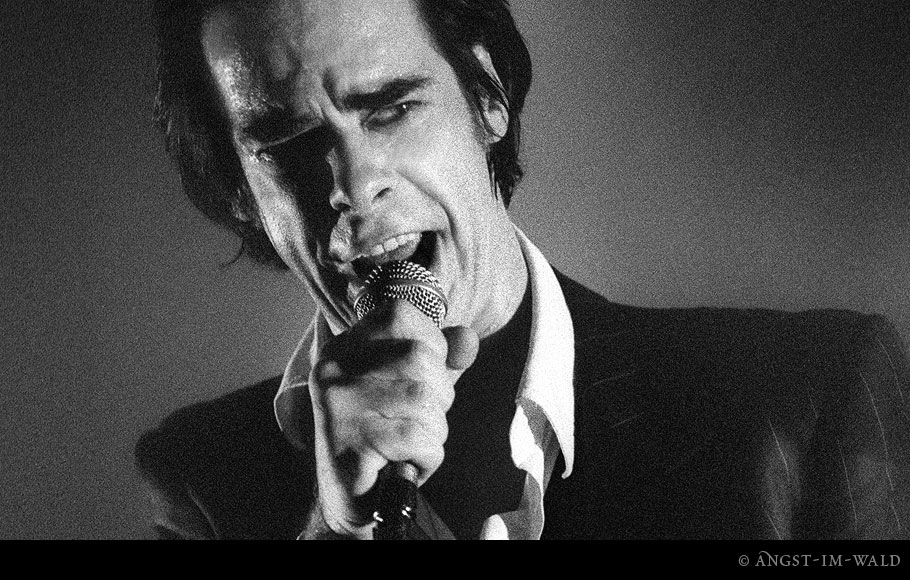Johnny works in a factory and Billy works downtown
Terry works in a rock and roll band lookin' for that million-dollar sound
And I got a little job down in Darlington but some nights I don't go
Some nights I go to the drive-in or some nights I stay home
I followed that dream just like those guys do way up on the screen
And I drove a Challenger down Route 9 through the dead ends and all the bad scenes
And when the promise was broken, I cashed in a few of my own dreams
Terry works in a rock and roll band lookin' for that million-dollar sound
And I got a little job down in Darlington but some nights I don't go
Some nights I go to the drive-in or some nights I stay home
I followed that dream just like those guys do way up on the screen
And I drove a Challenger down Route 9 through the dead ends and all the bad scenes
And when the promise was broken, I cashed in a few of my own dreams
Già, ci credi, ci credi come se fosse l'ultima cosa al mondo da fare, o meglio, l'unica. Johnny, Billy, Terry, tutti gli amici intorno lavorano duro, qualcuno perché c'è il pane da portare a casa, qualcuno perché crede solo in quello. Qualcun altro, invece, segue il proprio sogno. TU segui il tuo sogno. Sì, è vero, un lavoro ce l'hai, ma ti basta? No, ragazzo, te lo dico io: quel cazzo di lavoro non ti basta affatto. C'è da inseguire qualcosa di misterioso, qualcosa di più grande, qualcosa che assomiglia a quelle scene dei film che guardi là al drive in, quelle notti in cui decidi di non andare a ruscare duro ma te ne vai ad inseguire qualcosa, una promessa non meglio identificata. Un sogno. Forse, però è troppo attraente per essere solo immaginario. Per cui ci dai dentro, sali su quella macchina – d'altronde, l'hai detto tu stesso, è quella che hai barattato per le tue ali – e via, ad inseguire quel qualcosa. A quella macchina ci sei affezionato, vero ragazzo? Le sue portiere sembrano le porte di un'altra dimensione, dove tutto ha il fascino di qualcosa di nuovo da scoprire. Ma che cos'è che cerchi? Che cosa cerchi in mezzo a quello stridore di ruote, in mezzo a quelle immagini in bianco e nero, in mezzo a quella gente, in mezzo a quelle ragazze? Semplice, cerchi quella promessa. Cerchi te stesso, in fondo. Ma quella promessa, che cos'è? Ci puoi buttare dentro tutti i tuoi sogni, sicuro che non slittino e poi spacchino come il vetro della tua Challenger, quella volta che hai preso la curva troppo veloce e sei finito fuori strada?
Well now I built that Challenger by myself but I needed money and so I sold it
I lived a secret I should'a kept to myself but I got drunk one night and I told it
All my life I fought this fight, the fight that no man can ever win
Every day it just gets harder to live this dream I'm believing in
Thunder Road, oh baby you were so right
Thunder Road, there's somethin' dyin' down on the highway tonight
E così, ragazzo, l'hai venduta. Quella macchina era tutto per te, l'avevi messa insieme pezzo per pezzo, ci avevi buttato l'anima là dentro. Però la situazione è più grigia di quello che immaginavi. Avevi il tuo segreto, ma quella notte eri troppo esaltato per tenertelo dentro, e l'hai gridato ai quattro venti. E ora, dimmi, dimmi che cosa ti rimane in mano. Amico, lo so come ci si sente quando tutto ti rema contro, quando combatti fino a farti sanguinare le mani, quando ci metti tutto te stesso, tutta la forza di cui sei capace e forse anche di più e poi non concludi nulla. E resti lì, magari aspettando che squilli un telefono, che lei ti chiami, che succeda qualcosa che spezzi di colpo le catene dei tuoi pensieri. E invece nulla. Come fai a credere ancora a quei cazzo di sogni, a pensare che si possano vivere davvero. Eppure non molli, eppure ci provi, eppure continui imperterrito a sbatterci la testa, a prenderli a muso duro. La tua lotta sta diventando una lotta per la vita. Qualcuno, qualcuno in cui tu hai sempre creduto, chiedeva come ci si sente senza destinazione o casa, come un perfetto sconosciuto, come una pietra che cade giù e non può fermarsi se non sbattendo con violenza contro qualcosa d'altro. E ora cominci a capirlo. E a volte ti mancano le forze, però in qualche modo, non sai nemmeno tu come o perché, vai avanti, dritto, dietro al tuo sogno. Però, lo capisci anche tu, il tuo cuore funziona ancora, sai che qualcosa non torna. Cominci a capire che quella battaglia non la può vincere nessun uomo, neppure quegli eroi che guardavi con gli occhi sgranati al cinema fino a qualche giorno fa. Cominci ad accorgerti che qualcosa sta morendo, sta appassendo, che in fondo aveva ragione lei ad avvisarti. D'altronde, il più bel fiore del mondo, se lo sradichi dalla terra su cui è nato per stare, appassisce quasi subito. E tu, ragazzo, ora cominci ad accorgertene. La vecchia strada del tuono è diventata scivolosa adesso. C'eri arrivato perché ti sembrava la strada verso la vittoria, verso la tua redenzione, ma ora ti sembra solo un vicolo cieco, un altro fottutissimo vicolo cieco. Ma continui, perché in fondo oramai che cosa hai da perdere?
I won big once and I hit the coast, oh but somehow I paid the big cost
Inside I felt like I was carrying the broken spirits of all the other ones who lost
When the promise is broken you go on living, but it steals something from down in your soul
Like when the truth is spoken and it don't make no difference, somethin' in your heart turns cold
Thunder Road, for the lost lovers and all the fixed games
Thunder Road, for the tires rushing by in the rain
Thunder Road, remember what me and Billy we'd always say
Thunder Road, we were gonna take it all then threw it all away
In fondo all'inizio ti sembrava che il Destino fosse dalla tua parte. Ti sembrava di avere finalmente trovato la tua strada, di essere uscito trionfalmente da quella città di perdenti che ti eri lasciato alle spalle. Ma dimmi, cosa hai in mano adesso? Hai due soldi in più, magari, hai quello che prima avevi magari soltanto vagheggiato. Eppure ti basta? Te lo dico io, non ti basta. E' così, non ci puoi far nulla. Anzi, adesso sulle spalle hai anche il peso delle anime di quelli che hai incontrato sulla strada, come se non fosse già abbastanza faticoso portare il peso della tua, di anima. Loro sono come te, hanno i tuoi stessi desideri e la tua stessa inquietudine. La stessa identica tristezza. E tu vorresti togliergliela di dosso, ma come fai se non riesci a sopportare più nemmeno la tua? Dimmi, quella promessa era veramente reale? Piano piano qualcosa si sta spezzando dentro di te, e non riesci nemmeno a trovare i cocci per rimetterlo insieme. Certo, continui a vivere, ma è per inerzia, è come se tutto ti passasse addosso, gocciolasse via poco a poco come acqua dalle mani. E arrivi al punto che nemmeno più il Vero può scalfire il marmo dei tuoi pensieri. Non te ne rendi più conto, sei come narcotizzato, cauterizzato da quella bruciatura che ti hanno lasciato le tue promesse quando sono esplose senza preavviso. Il tuo cuore si è raffreddato, dici. Ma è proprio vero? E allora perché cazzo scrivi queste cose? Ne sei proprio sicuro? Anch'io sono come te, anch'io ho quel peso che mi prende al petto tutti i giorni. E ti capisco, ti capisco eccome. Il telefono è ancora lì muto, anche se tu aspetti che quel vecchio amore ti chiami una santa volta. Le gomme slittano, è tutto bagnato ed oramai è diventato quasi impossibile tenere la strada. Sì, tu e Billy lo dicevate sempre, che sareste arrivati a tenere in mano il mondo intero ma nemmeno questo vi sarebbe bastato, e così lo avreste buttato via con le vostre stesse mani. Eppure, nonostante tu non voglia ammetterlo, a quella promessa sotto sotto ci credi ancora. E quel fuoco che ti aveva portato via da casa tua brucia ancora sotto la cenere delle tue delusioni. E d'altronde, anche se non ce la fai ad ammetterlo, quella promessa è ficcata dentro di te. Ed anche dentro di me. Perché la nostra domanda in fondo è sempre la stessa. Forse qualcuno ci ha promesso qualcosa? E allora perché aspettiamo?